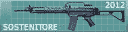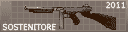Contro questi potentissimi combattenti del web esiste una sola tattica: cambiare il dominio da .it a .Como/Otranto/Mantova (scrivo le città così non capiscono il codice!), allora non saranno più in grado di trovare il sito così offuscato e crederanno di averci battuto!


 Portale
Portale Lo staff
Lo staff








 In attesa della conferma e-mail
In attesa della conferma e-mail